Psicoterapia Psicoanalitica
Troviamo insieme un miglior equilibrio.
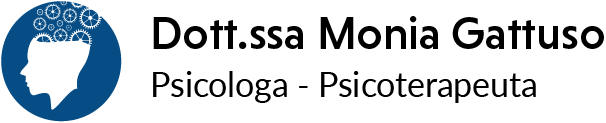
Con l’invecchiamento della popolazione accade sempre più spesso di incorrere in problemi di tipo cognitivo. Le persone iniziano a soffrire di mancanza di memoria, di attenzione, o non si sentono più pronte mentalmente come prima. Tutto ciò potrebbe essere un fisiologico calo delle prestazioni, oppure essere l’esordio di problematiche cognitive. La valutazione neuropsicologica dell’adulto è entrata ormai a far parte della routine clinica nello studio di molte sindromi e patologie che possono alterare il normale funzionamento cognitivo. Ecco perché è buona profilassi uno screening delle funzioni cognitive se si avvertono dei problemi in questo ambito.
Lo screening delle funzioni cognitive consiste in un colloquio anamnestico e nella somministrazione di brevi test per l’esplorazione generale delle funzioni cognitive. Consente di monitorare brevemente le principali funzioni cognitive e di avere un’idea circa lo stato di salute cognitivo della persona. Qualora il semplice screening dovesse fornire elementi di dubbio, è indicato procedere per una valutazione neuropsicologica completa.
La logica sottostante a tale approccio è lineare: in un individuo con un normale sviluppo delle funzioni cognitive, un danno acquisito provoca disturbi specifici in uno o più domini neuropsicologici. Una batteria di test standardizzati e validati permette con un elevato grado di accuratezza di evidenziare quali siano i meccanismi danneggiati e quali siano i processi rimasti integri.
L’ Esame Neuropsicologico Completo, come quello utilizzato da anni dalla dott.ssa Gattuso, prevede la somministrazione di molti test utili all’indagine obiettiva dello stato cognitivo del paziente. Quali informazioni si possono cogliere con una indagine neuropsicologica? Fornisce preziose informazioni e dati clinici sul comportamento, le capacità cognitive, la personalità, le abilità apprese, il potenziale riabilitativo delle persone che hanno subito un danno cerebrale.
La valutazione neuropsicologica si propone di chiarire se:
Metodologia e strumenti impiegati per la valutazione neuropsicologica.
I punteggi ottenuti sono corretti per età e scolarità, rapportati ad ampi campioni statistici. La valutazione contribuisce a:
Sembrerà strano, ma non è facile rispondere a questa domanda. Intanto stiamo parlando di una
psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, perché ci sono diversi tipi di psicoterapia. Forse
bisognerebbe chiedersi perché si sta intraprendendo una psicoterapia e chi lo sta facendo. Si,
perché le cose cambiano molto in base al mutare di queste variabili. Le persone non sono tutte
uguali, non hanno tutte la stessa età, la stessa personalità o la stessa motivazione, anche se
apparentemente sembrano soffrire dello stesso disturbo. Quindi non sovrapponete mai le stesse
situazioni perché ciò che è andato bene per una persona può non calzare allo stesso modo per
un’altra.
Detto ciò, è buona prassi iniziare con 3-4 incontri di conoscenza ed approfondimento della
conoscenza fra paziente e terapeuta. Insieme si deciderà la cadenza delle sedute che è
raccomandato siano regolari. Non è possibile stabilire a priori la durata complessiva di un
trattamento psicoterapico. Ciò dipenderà anche dagli obbiettivi che si vorranno raggiungere in
terapia, se il semplice superamento sintomatico o una vera e propria ricerca introspettiva di sé.
Qualunque sia il lavoro che si vorrà intraprendere, sarà sempre possibile concordarlo liberamente
e nella massima sincerità con lo psicoterapeuta.
La psicoterapia psicoanalitica è come un abito sartoriale su misura: verrà cucita addosso ad ogni
paziente e sarà alla sua misura, se egli gli consentirà di farlo.
Si. E’ uno dei capisaldi della professione: il segreto professionale. Uno psicologo è tenuto al segreto professionale per legge, etica e deontologia. E’ necessario mantenere il segreto professionale perché altrimenti non sarebbe possibile stabilire alcun rapporto fiduciario con il paziente. Nemmeno se si tratta di un minore è possibile rivelare i contenuti di quanto riferito in terapia. Fanno eccezioni solo i casi in cui è a repentaglio la salute fisica o psichica del paziente o si ha ragione fondata di credere che il paziente stia per commettere un atto lesivo verso sé o verso qualcuno, oppure un reato. Diverso è se il paziente ha già commesso un reato; quello ricade nel segreto professionale e non può essere rivelato. Se ad esempio si riceve la telefonata di qualche familiare, pur in buona fede, magari preoccupato, si ha l’obbligo di riferire al paziente che si è stati contattati da tal familiare. Nel caso di un paziente minorenne, possono essere previsti degli incontri con i genitori, ma non si potranno rivelare i contenuti delle sedute con il minore, eccetto quei casi in cui si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Chiunque sia disposto a mettere in discussione sé stesso ed il
proprio assetto interiore.
Per le sue caratteristiche strutturali di minore intensità e
frequenza, si sarebbe portati a pensare che un trattamento di
sostegno sia una specie di cenerentola a confronto della
psicoterapia dello stesso orientamento teorico o che sia
indicata nei casi più “semplici” necessitanti un minore impegno.
In effetti così non è. Esistono casi per i quali non è possibile o
non è opportuno approfondire il trattamento nel senso di una
maggiore enfasi espressiva. Sarà perciò fondamentale valutare
insieme al paziente la forma di terapia più idonea. Gli strumenti
teorici di questo tipo di trattamento psicologico sono sempre
quelli ispirati alla psicoanalisi, quindi la formazione del
terapeuta deve essere la medesima. Qualsiasi trattamento a
matrice psicoanalitica mira alla presa in carico globale della
persona, ma ci sono persone che vogliono occuparsi del loro
malessere dal punto di vista della manifestazione acuta di esso.
Ecco in quel caso questo non è il loro trattamento. Partendo dal
presupposto che l’essere umano è un insieme complesso di
molti fattori eterogenei che interagiscono e si influenzano
reciprocamente ed in continuazioni, la focalizzazione sul solo
sintomo, dà dell’individuo una visione monodimensionale
artificiale e fuorviante. Pur tuttavia non è infrequente anche in
questo tipo di approccio vedere remissioni sintomatologiche
avvenire in qualche mese. Distinguiamo però il benessere dalla
remissione sintomatica: il primo si ottiene con una riorganizzazione generale dell’equilibrio psichico della persona
e può essere un obiettivo di secondo livello del trattamento
psicologico; la seconda è un risultato di primo livello, si ottiene
in un tempo più breve perché coincide col superamento di una
fase acuta, non è detto che non si ripresenti se non si raggiunge
l’obiettivo di secondo livello che è l’equilibrio psichico di cui si è
parlato prima.
La risposta è si. Vale sempre il principio per il quale vige la segretezza della psicoterapia e l’assoluta riservatezza dei contenuti dei colloqui psicologici che avvengono senza la presenza dei genitori. Bisogna però precisare che se si è minorenni non si può sostenere un trattamento psicoterapeutico senza il consenso dei genitori, di entrambi i genitori. Infatti è buona norma che, anche se fosse il minore il destinatario delle cure psicoterapiche, vengano fatti i colloqui iniziali con entrambi i genitori i quali sono chiamati a dare il loro consenso informato tramite la sottoscrizione di un documento scritto che specifichi i termini e le modalità della cura psicoterapica. Questo a sottolineare la serietà e la delicatezza del lavoro che si svolge con i pazienti minorenni, oltre la fondamentale importanza della collaborazione della famiglia nella cura dei minori.
Nel linguaggio comune molto spesso questi termini sono interscambiabili e si sovrappongono. Non è un
semplice fatto linguistico, anzi, ciò denota la confusione che regna nell’ambito di ciò che è psicologico. Non
è infrequente altresì usare termini come “strizzacervelli” per indicare una qualsiasi di queste figure. Eppure
stiamo parlando di diversi professionisti e tutti con specifiche diverse per giunta stabilite per legge.
Lo Psicologo.
E’ un professionista della salute mentale con laurea magistrale in Psicologia ed abilitato all’esercizio della
professione tramite il superamento di un esame di Stato che può sostenere solo dopo un anno di tirocinio e
l’iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione di appartenenza. La professione di Psicologo è ordinata
dalla Legge 18/02/1989, n. 56, ed è disciplinata dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L’articolo 1
definisce gli ambiti e le modalità di intervento: “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e
di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. L’Ordine degli Psicologi
Nazionale ha deciso di specificare quali sono gli atti tipici della professione dello Psicologo, ovvero cosa è
proprio della professione di Psicologo, proprio per cercare di fare chiarezza. Tali atti tipici sono:
Prevenzione, Diagnosi, Abilitazione e Riabilitazione, Sostegno e Consulenza (Counseling). Tutto ciò fa
dello Psicologo una figura molto versatile che può applicarsi a svariati campi della salute mentale
dell’individuo, della coppia, della famiglia, della comunità, in qualsiasi età di vita ed in qualsiasi aspetto in
cui si svolge la vita stessa anche come ruolo, oltre che come condizione.
Lo Psicoterapeuta
Lo psicoterapeuta è di base uno Psicologo abilitato all’esercizio della professione e quindi già iscritto
all’albo degli Psicologi della Regione di appartenenza, ma in più ha frequentato una specializzazione
universitaria oppure una scuola di specializzazione post lauream accreditata c/o il Ministero della Pubblica
Istruzione e dell’Università, della durata minima di 4 anni ed ha conseguito il titolo di Psicoterapeuta dopo
un esame finale di profitto. Anche i medici possono iscriversi ad una scuola di specializzazione in
Psicoterapia e conseguire il titolo di Psicoterapeuta seguendo lo stesso iter degli Psicologi. Vi sono diversi
tipi di scuole di specializzazione in Psicoterapia, in generale tutte richiedono per legge un numero minimo
di ore di psicoterapia personale degli specializzandi come atto propedeutico formativo, ma le scuole di
specializzazione ad orientamento psicoanalitico fanno dell’analisi personale un punto centrale della
formazione dello psicoterapeuta ed elemento fondamentale della forma mentis dei candidati e futuri
psicoterapeuti.
Lo Psichiatra
Lo Psichiatra è un medico prima di tutto, iscritto all’albo dei medici ed abilitato all’esercizio della
professione medica. Può prescrivere di conseguenza farmaci e compiere tutti gli atti tipici della professione
medica. Lo Psichiatra è quindi un medico che ha inoltre conseguito la specializzazione in Psichiatria. Per
legge lo Psichiatra può condurre delle psicoterapie, pur non essendo stato formalmente istruito in alcuna
tecnica di conduzione. E’ proprio per colmare tale vuoto che diversi Psichiatri decidono di moto proprio di
frequentare una scuola di Psicoterapia, qualora volessero cimentarsi nella cura psicologica delle persone
affette da psicopatologie. Esiste infatti una differenza fra cura medica e cura psicologica; esse non sono in
contraddizione, anzi, accade sempre più spesso che Medici Psichiatri e Psicoterapeuti collaborino lavorando
in equipe occupandosi ciascuno dei diversi ambiti della cura del paziente, con risultati senz’altro più proficui
in termini di efficacia e di tempi di sviluppo.
Lo psicologo non è un medico quindi non può prescrivere farmaci. Spesso come psicologi e psicoterapeuti ci
troviamo ad avere in trattamento persone che fanno uso di farmaci o, più specificatamente, di
psicofarmaci. Accade che sia necessario farne uso e che sia indicato, quindi ci troviamo a lavorare di
concerto con medici specialisti come neurologi, psichiatri o neuropsichiatri infantili se si dovesse trattare di
casi di minori. La collaborazione risulta fruttuosa ed assolutamente benefica per i pazienti, dato che è ormai
dimostrato come la combinazione di psicoterapia e terapia farmacologica, una volta considerate in
alternativa fra di loro, in realtà si potenziano vicendevolmente assicurando un benessere maggiore,
raggiunto in minore tempo, con un’indipendenza più probabile da parte del paziente da entrambe le
tipologie di terapia.
Ma bisogna sempre valutare caso per caso. Non è infrequente la prescrizione frettolosa di farmaci a
persone molto giovani, le quali potrebbero ancora tentare con la sola psicoterapia o, viceversa,
l’evitamento ostinato di psicofarmaci in casi nei quali si permane nella più buia sofferenza solo per paura o
pregiudizio. L’affidamento a professionisti seri e preparati può evitare molta sofferenza.